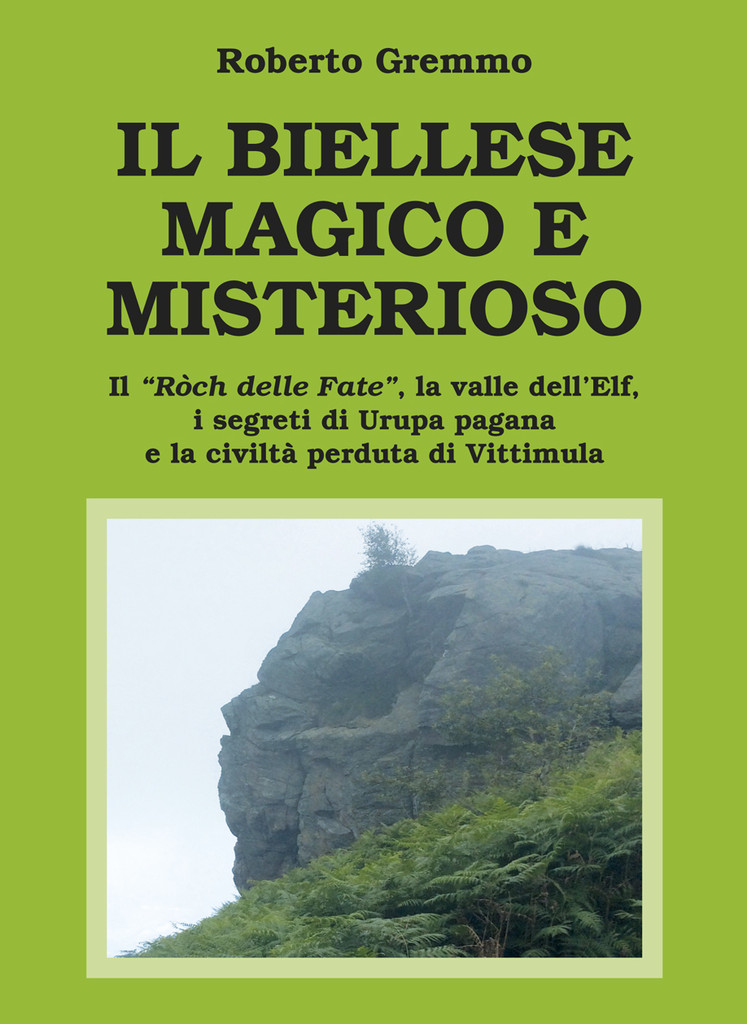Il 18 dicembre 1893 nasceva a Fobello Mario Tancredi Rossi che é stato uno dei primi ed obiettivi studiosi d’un personaggio controverso come Fra Dolcino,
Doveva morire giovanissimo nelle trincee dell'Ortigara nel grande macello mondiale gettandosi nella grande mischia spinto da ideali nazionalisti, cui credeva ciecamente con quella sensibilità poetica che gli era propria e che gli faceva vedere nel mito italico il naturale contr'altare all'amore per la sua Valle e le sue tradizioni.
Mario Tancredi Rossi è stato autore di composizioni poetiche da cui traspaiono religiosità intensa, malinconico appagamento nella maestosità alpina infine un forte nazionalismo.
Le sue composizioni vennero pubblicate, postume,nel 1927, da una editrice non a caso chaimata "Eroica", per cura di Antonietta Belazzi e S. Sottile Tomaselli mentre le corrispondenze patriottiche e politiche vennero date alle stampe in un'edizione curata da Vittorio Cian con un titolo che non lascia adito a dubbi di sorta: "Lettere d'un Eroe”.
Nelle sue poesie si cantano i giovanili amori per la natura, una fede religiosa cristallina, il nazionalismo.
Ma Mario Tancredi-Rossi è stato un misconosciuto, obiettivissimo, studioso di Fra Dolcino.
Finora, i moderni rievocatori dolciniani non hanno ritenuto di dare rilievo al suo lavoro.
Ed hanno fatto male, perchè il lavoro di Tancredi-Rossi ribadisce con equilibrio alcune verità storiche.
E' un saggio pubblicato postumo, nel 1921, per cura di A. Viglio in una antologia dantesca novarese.
Il Viglio informa che si tratta di un manoscritto datato Varallo 1915 dove il giovane Rossi “non difende il ribelle, ma ne prova un senso di ammirazione: lo condanna come Cristiano, lo ammira come uomo...non si può negare che la figura di Dolcino emerga e giganteggi drammaticamente sullo sfondo dei monti precipiti e vertiginosi della Val di Rassa, nell'ambiente feroce ed appassionato del Medio Evo; non si può negare che il coraggio dell'eresiarca valsesiano fosse degno di ammirazione per la lotta ingaggiata con pochi seguaci, senza pietà e senza quartiere, contro le forze religiose e civili alleate nella caccia di distruzione, non si può negare che tale uomo dovesse possedere qualità morali e fisiche di condottiero se seppe reggere, nelle condizioni più disperate di tempo e di luogo, e condurre sino all'estremo supplizio del rogo la sua donna e i suoi fidi a cui non aveva promesso altro che la fame, gli stenti e la morte per l'ideale di un mondo restituito alla primitiva semplicità e purezza della vita. Non è quindi meraviglia che sia sorto nell'animo di un giovane tutto ardore di sentimento il desiderio di rievocare la tragedia di Dolcino”.
Con tutta probabilità, la motivazione più profonda dell’interesse dolciniano di Rossi stava nella ‘memoria’ popolare valsesiana, ben differente da quella dell'egemonismo ecclesiastico.
Infatti Rossi spiega la durezza dell'epopea dolciniana, le razzie, le violenze partendo dalla realtà dei luoghi e dei tempi, che mostra di conoscere bene. In particolare la Parete Calva “cupa, massiccia, drizzata verso il cielo che pare una immane ombra nera sfidante la chiarità dell'azzurro sulle montagne. Protesa a picco sugli abissi, da una parte, e in fondo agli abissi, foschi alberi di abete, di larice e di pino, giunchiglie serpeggianti, aride graminee e macigni spaccati, o neri o adamantini; dall'altra parte, legata al filone della montagna su cui pende per un salto accessibile sì, ma non valicabile se alcuno di sopra si difenda”.
Il giovane studioso non ha alcuna remora nel sottolineare responsabilità che non possono essere ascritte alla sola parte dei ribelli perché “la crudeltà dei cattolici non é minore”.
E non basta.
La conoscenza diretta dei luoghi gli suggerisce importanti riflessioni che lo convincono della larga inesattezza delle ricostuzioni della storiografia ufficiale, di parte cattolica: “Mai avvenuta è la battaglia di Campertogno tra Dolcino e gli alleati perchè, secondo me, non si spiega come essa possa essere successa a metà strada fra Varallo e Alagna e cioè nel cuore della Valsesia, fra novaresi, vercellesi e dolciniani, senza che gli abitanti delle valli, certamente già danneggiati dagli eresiarchi, vi avessero dato aiuto e ne tramandassero memoria”.
Mario Tancredi Rossi non nasconde la sua simpatia per Dolcino che “appare come una tempra di eroe mistico” e giganteggia la figura dell'indomita Margherita di “immensa bellezza”.
Quasi a scusare l'ardire di una rivisitazione, il Rossi scrive con grande modestia che su Dolcino “non è possibile dire nuove cose” ed è forse anche vero: ma il suo lavoro ripropone antiche realtà con toni affascinanti. Ed è perciò prezioso.
Non è difficile capire che per il giovane valsesiano i confini fra poesia e storia sono labili ed indistinti. Nella magia della sua Valle ha forse trovato il ‘tesoro’ di Dolcino.
Nella tragedia delle Valli alpine dov’era stato gettato dalla guerra aveva incontrato, invece troppo presto la morte.
Saremo grati a chi vorrà segnalarci realtà analoghe a quelle esaminate in questo articolo scrivendo a storiaribelle@gmail.
Per approfondire questi argomenti segnaliamo un libro pubblicato da Storia Ribelle casella postale 292 - 13900 Biella.